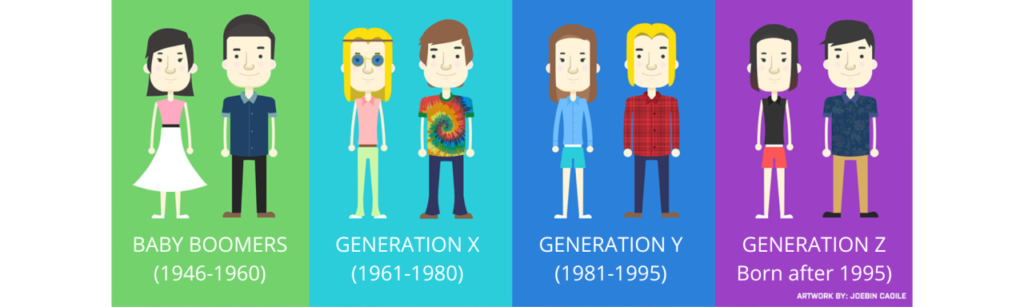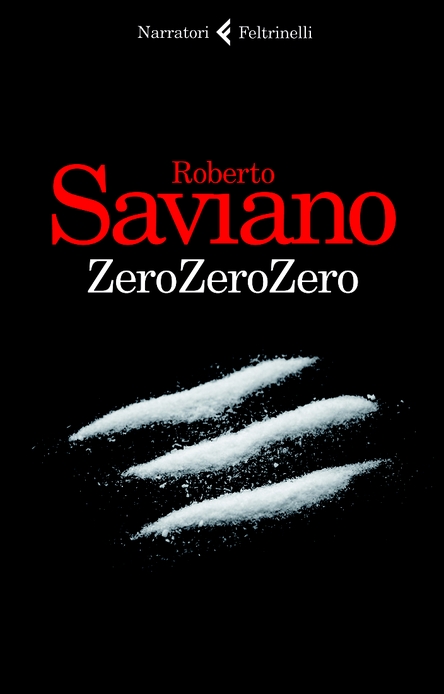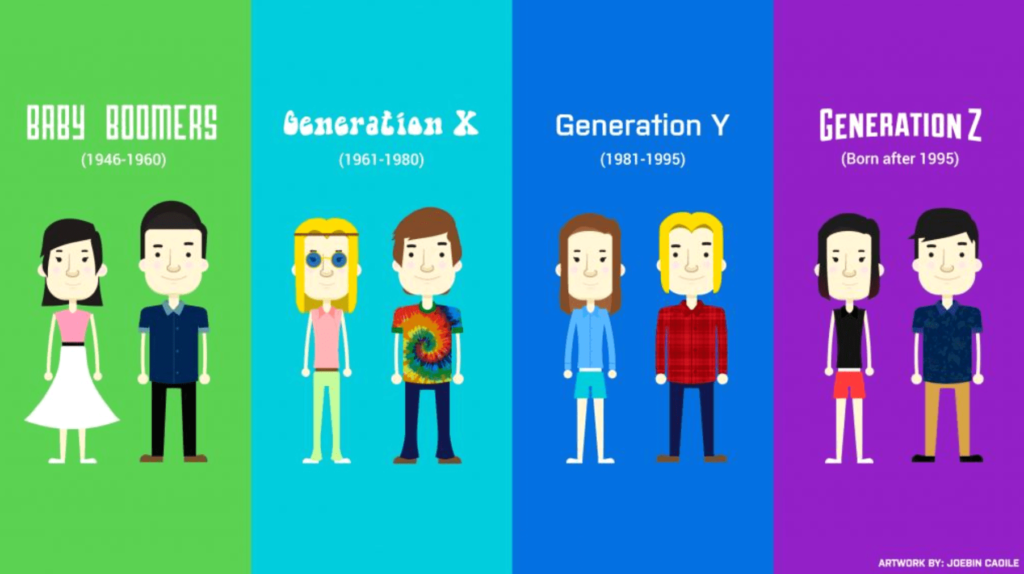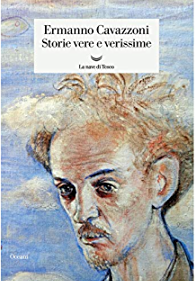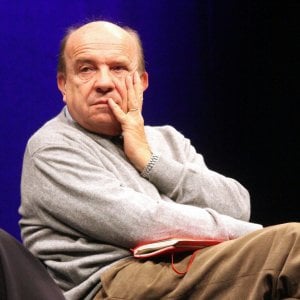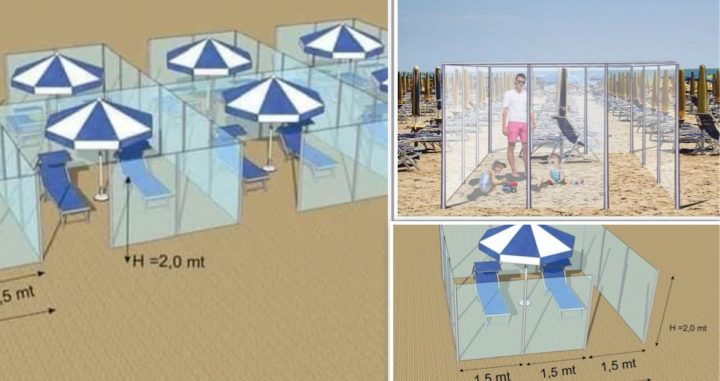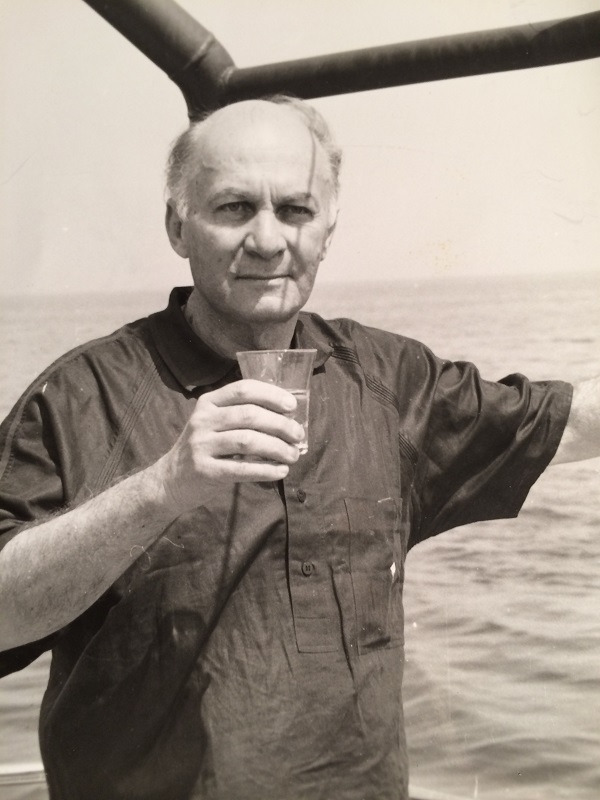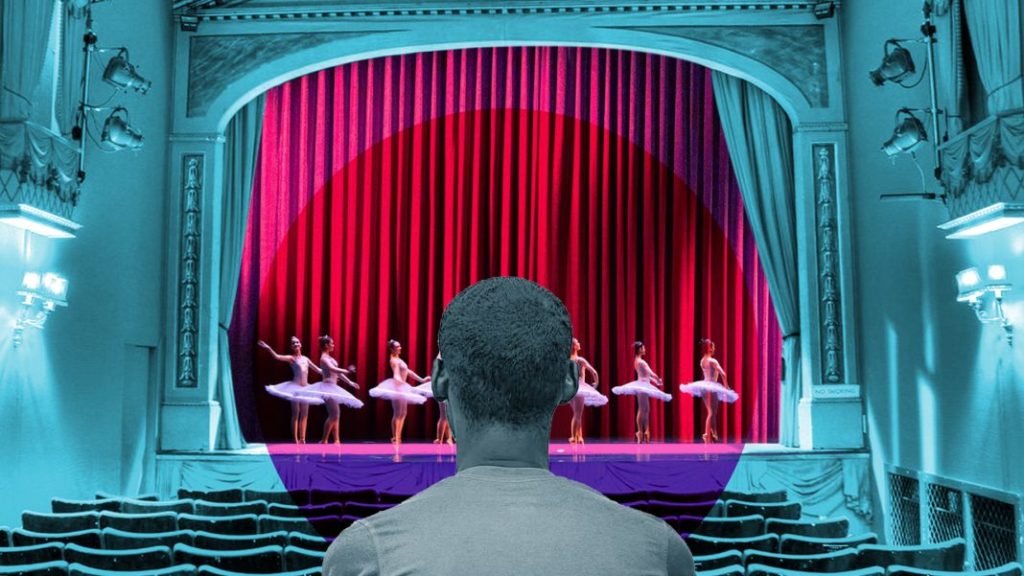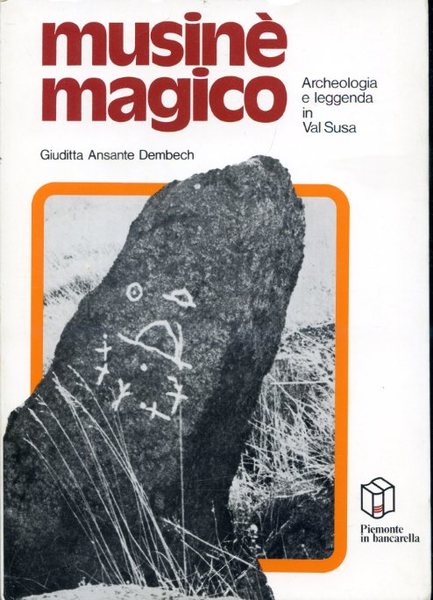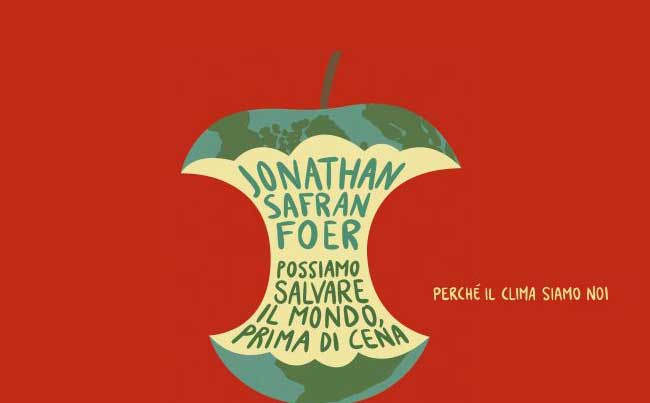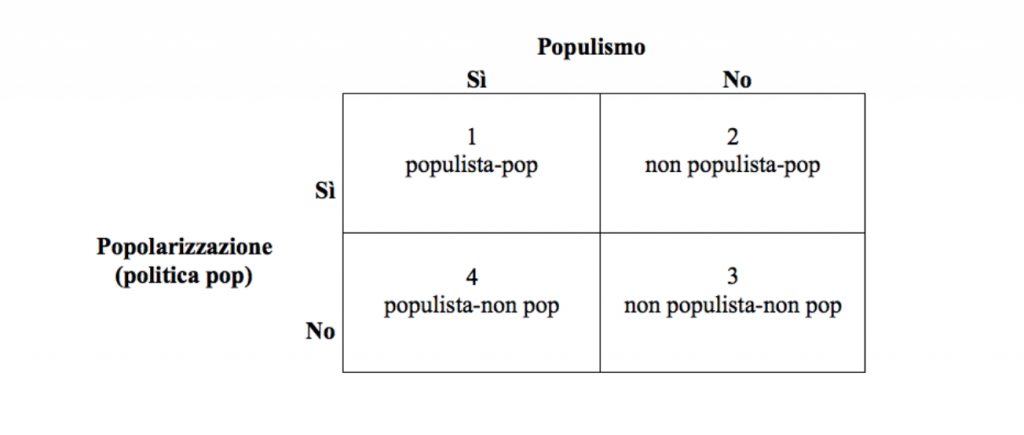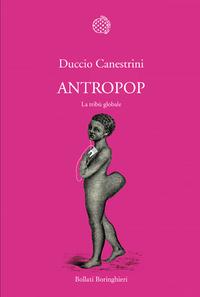Per gli ignoranti e i pigri come me, c’è un’occasione fantastica per prendere possesso in maniera sufficientemente esaustiva di quello che è successo circa l’ascesa e la caduta del fascismo.
L’occasione è la saga di “M”, ovvero l’opera di Antonio Scurati.

Una quadrilogia di enorme successo, a partire dal primo libro uscito nel 2019, l’ultimo in libreria da quest’estate.
Sul piano personale, affrontare “M” è stato come intraprendere un percorso che mi ha entusiasmato e turbato… per questo ho bisogno di scrivere e, soprattutto, scrivermi addosso.
È tutto partito fin dal primo libro.
Mi sono sentito immerso in un mare di emozioni e cortocircuiti.
Da un lato il fascino verso l’Uomo del Secolo, il suo modo di parlare, di trovare sempre la sintesi, la sua capacità di essere sempre “Lui”, Mussolini.
Dall’altra, l’incredulità dello scenario, chiaro dalla lettura di Scurati, per cui ti rendevi conto dai documenti e dal corso degli eventi che avevi di fronte un cialtrone.
Bene… quel cialtrone romagnolo, non so perché, l’ho sentito molto vicino.
Fin dalle prime pagine, malgrado tutta la negatività che sappiamo, quell’uomo era davvero l’affascinate Figlio del Secolo.
La saga di Scurati è scritta in maniera assolutamente originale: le pagine scorrono a brevi e a volte brevissimi capitoli, dove, alla fine di ognuno, sono riportate le sintesi di documenti, telegrammi, telefonate intercettate, lettere che testimoniano ciò che è stato scritto.
Insomma, sei dentro, dentro a quel secolo e a quegli strazianti eventi.
Ce l’hanno raccontato in tanti che la Prima Guerra Mondiale ha creato la frattura tra l’epica romantica e la guerra moderna.
Lo stesso Scurati nel libro “Guerra” (di cui consiglio di leggere anche soltanto la bellissima e profondissima sua introduzione) ci dice che quel conflitto fatto di trincee, gas nervino e malattie non poteva più avere niente a che fare con la battaglia risorgimentale, né tantomeno con lo spirito cavalleresco.

Con le maschere antigas, l’etica della battaglia se n’è andata a quel paese.
Già La Grande Illusione di Jean Renoir (1939) ha ben raccontato la fine di quel romanticismo.

Romanticismo che comunque attraverso il Senso della Patria e l’atto del sacrificio eroico della Grande Guerra ha comunque continuato a dare manforte al Potere e alla sua Propaganda.
Ancora oggi c’è chi capitalizza (strumentalizza?) gli Arditi.
Per dirla come quelli bravi, “M”, in tutti i suoi 4 libri, ha evidenziato come la realtà sia “un oggetto socialmente negoziabile”.
La frase, assolutamente efficace, è una citazione dall’ultimo libro dell’amico Daniele Chieffi dedicato al Crisis Management (a cui dedicherò un prossimo segnale debole).

Ma “M” ha anche evidenziato il fascino di “Lui”, dell’uomo che sa sempre cosa dire e lo sa dire con la sintesi giusta, con l’epitaffio o il peana, per cui ogni discorso diventa un’affascinante sentenza, dove tu che ascolti non hai modo di replicare con la medesima efficacia, a meno che non inizi a metter su discorsi e spiegazioni lunghissime… lontanissime dall’efficacia necessaria.
È un po’ il solito discorso di sempre… parafrasando “Per un pugno di dollari”: l’uomo che con un discorso incontra l’uomo con uno slogan, quello con il discorso è un uomo morto.
Il tutto a prescindere spesso (troppo spesso) dal contenuto.
Lo vediamo in Trump.
È evidente nei suoi discorsi e sproloqui, che risultano assolutamente efficaci per il suo elettorato.
Trump dice sempre le stesse cose, reiterate più volte nello stesso discorso, senza costruzioni narrative coerenti, senza alcun filo conduttore tra un tema e l’altro: l’importante è reiterare quel concetto che sei sicuro che passi.
I discorsi di Trump sono come la sua immagine: il suo abito, i suoi capelli, la sua cravatta rossa sono come il costume di Capitan America, come la canotta di Hulk Hogan, la M di McDonald’s, il blue della Pepsi e il rosso di Coca-Cola.

I suoi discorsi devono essere come la sua immagine iconografica: sempre gli stessi, con gli stessi concetti che devono emergere almeno ogni 4 minuti… sennò chi ascolta si perde.
E i cortocircuiti cognitivi? Le contraddizioni? Gli elementi
che non tornano?
Come si è visto, per noi elettori, spesso l’onestà intellettuale va in secondo
piano.
Facciamo un esempio…
Trump si presenta come il negazionista climatico numero uno… e al suo fianco c’è Elon Musk.
Se chiedete a Musk perché crede nelle auto elettriche (Tesla) e nel treno super veloce su cuscino d’aria (HyperLoop), in un contesto differente vi darà anche motivazioni legate alla sostenibilità e salvaguardia ambientale.

Eppure…
Proseguendo con i cortocircuiti su Musk, in tanti si sono convinti che la stessa persona che ha trasformato Twitter in X licenziando oltre 6.500 dipendenti, sia l’uomo giusto (il Figlio del Millennio?) per rimettere in riga un apparato pubblico troppo pesante da mantenere, con la convinzione che l’umanità debba reggersi non con stupidaggini tipo, ad esempio, la sussidiarietà, ma con la selezione naturale.
E tutto questo provoca fascino.
Lo provoca, l’ha provocato e lo provocherà ancora.
D’altronde non c’è stato più convinto e affascinato fascista dell’alpino Mario Rigoni da Asiago, decorato eroe di guerra della Compagnia Stern… salvo poi diventare, attraverso i suoi libri, testimone sublime di una realtà vissuta e non “negoziata”.

Il mito dell’italiano buono in guerra…
Il mito dell’efficienza fascista…
Il mito della potenza militare imperialista italiana…
Tutte cialtronate.
Diceva bene Churchill, come riportato da Scurati: perché si è messo in guerra un popolo abituato a vivere in mezzo alla bellezza?
Insomma, siamo vittime del pensiero pigro e facilmente collocabile.
Per l’essere umano è difficile e laborioso approfondire, piuttosto che farsi bastare un luogo comune o uno slogan: bastano i primi 10 minuti di una lezione di neuromarketing per prendere coscienza di questa tesi.
Ciò non toglie che fin quando giudicheremo un leader politico semplicemente dalla sua capacità di essere efficace semplicemente attraverso la frase giusta, la mimica simpatica, o il gesto autorevole, ci troveremo i Trump a decidere le sorti del nostro mondo.
E, allo stesso tempo, pensare che a votarlo sono stati solo gli stupidi, è un altro luogo comune, un altro slogan, l’ennesimo bias cognitivo.